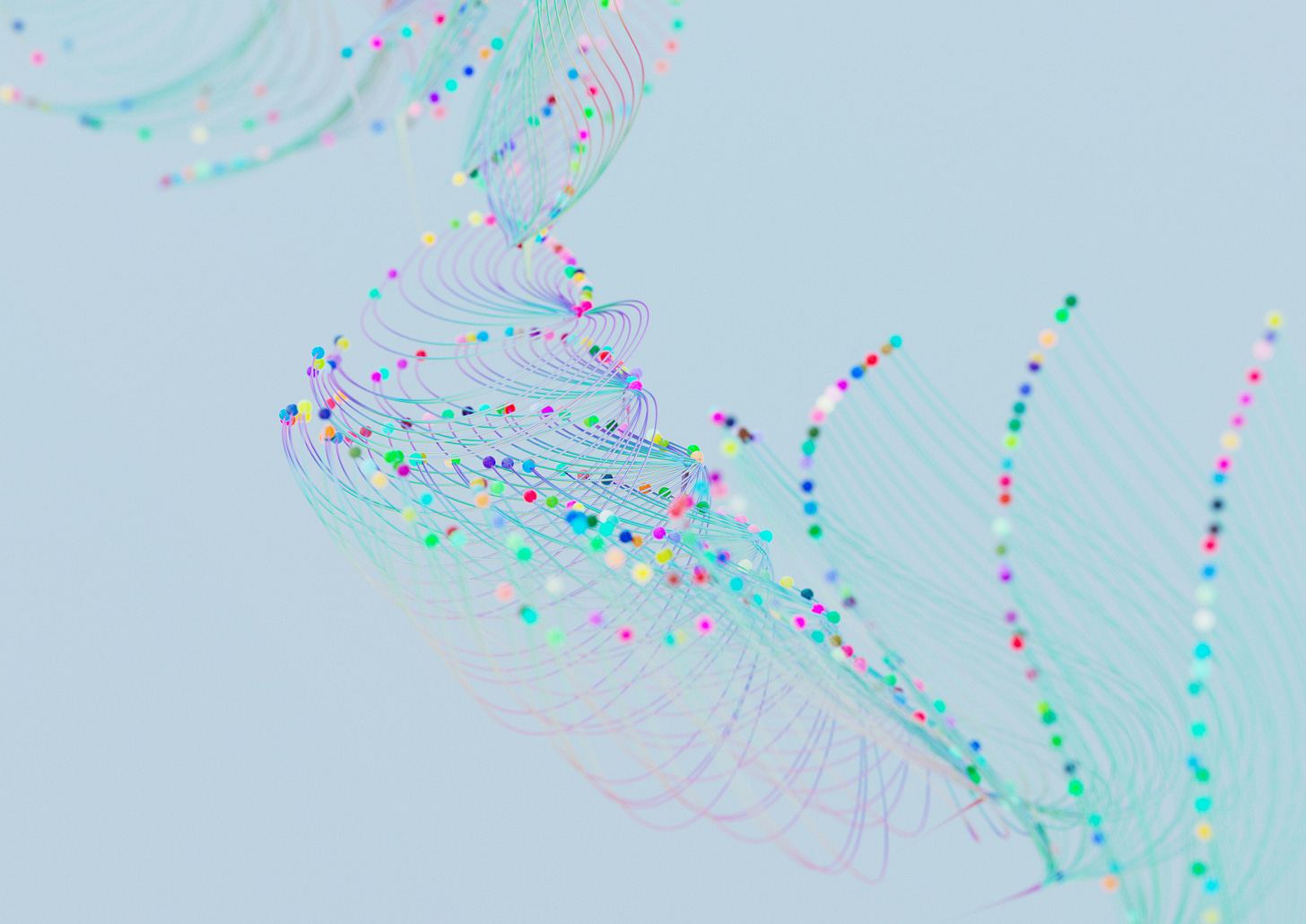CURA
Un mese di febbre e riflessioni sulla delicatezza dei dati
Dati sensibili è la newsletter di BUNS che arriva due volte al mese, il 7 e il 21.
Ogni numero parte da una parola sola. Una parola che sembra semplice, ma che se la giri e rigiri diventa un prisma: autobiografia e cultura pop, trend digitali e storie personali, dati e intuizioni. Non troverai spiegoni né retorica: solo un invito a guardare i nostri dati e le nostre vite con uno sguardo più attento, più umano, più sensibile. Questa è la prima, che vuole suonare e risuonare quasi come un manifesto.
(un po’ sgangherata, con tante cose da sistemare ancora)
Bene ma non benissimo
Sono tornata dalle vacanze e mi sono ammalata.
Un mese intero. Quattro settimane in cui il mio corpo ha deciso di fermarmi: febbre, tosse, otite bilaterale, antibiotici, cortisone, aerosol, e poi ancora bronchite. Ero stufa di me stessa, ma soprattutto mi sono trovata davanti alla parola che apre questo primo numero di Dati sensibili: cura.
Prendersi cura di * non è mai glamour. Non ha niente a che fare con le foto patinate di riviste wellness. È piuttosto una faccenda di termometri sballati, medicine che non fanno effetto subito, giornate saltate, pigiami che hanno quell’odore lì, messaggi di lavoro rimandati. La cura inizia quando smetti di fingere che vada tutto bene e accetti di rallentare. È un gesto banale e sovversivo: fermarsi.
Ma la cura non riguarda solo il corpo. Vale anche per i dati. Viviamo dentro un flusso continuo di informazioni prodotte e ricevute. Foto, note vocali, chat, preferenze, playlist, scelte di consumo. Tutto questo è “sensibile” in entrambi i sensi: perché va maneggiato con attenzione (un like, un click, una ricerca non sono neutri), e perché racconta qualcosa di noi che è fragile, emotivo, delicato. I dati hanno una loro vulnerabilità, e hanno anche una loro emotività.
La vera cura, allora, non è solo proteggerli con password o consensi, ma anche ascoltarli. Leggerli con quella sensibilità che permette di cogliere storie, non solo numeri.
Per me dati sensibili significa questo: non un tabù, non un tecnicismo, ma la possibilità di maneggiare il nostro mondo digitale come si fa con un oggetto prezioso. Non perché valga milioni sul mercato, ma perché ci rappresenta.
La cura riguarda anche le scelte che facciamo nel nostro consumo culturale. Non è un caso che, in tempi di fatica da algoritmo, le persone stiano tornando a fidarsi di voci umane. Nella musica, per esempio: dopo anni di playlist infinite e suggerimenti automatici, sempre più ascoltatori cercano curatori in carne e ossa, DJ, blogger, giornalisti, radio indipendenti.
Perché?
Perché l’algoritmo ti dà quello che già sai di volere.
Ti intrappola in un eterno presente: le stesse canzoni, gli stessi video, gli stessi format. Una culla confortevole che a lungo andare stanca. È nostalgia per i mixtape degli anni Novanta? Forse, ma è soprattutto una richiesta di cura.
Pensate a progetti come i Bandcamp Clubs, dove per pochi euro al mese entri in una community guidata da un curatore, che non ti “spara addosso” brani random ma ti racconta perché un album o un artista meritano il tuo tempo. Non è un algoritmo che calcola il tuo “engagement”: è un essere umano che ha fatto la fatica della ricerca, che ti fa da filtro, da narratore, da ponte.
Lo stesso succede con piattaforme come Somewhere Soul, che ha costruito una community di quasi due milioni di persone attorno a nuove scoperte musicali di jazz e soul. O con i DJ che organizzano serate sold out non perché hanno trovato la formula virale su TikTok, ma perché hanno coltivato pazientemente un pubblico affezionato. È un modello che mette al centro la cura per gli artisti e per chi ascolta: non la viralità effimera, ma la relazione lunga.
E non riguarda solo la musica. È un comportamento che sta emergendo ovunque: dal preferire newsletter fatte da persone con un punto di vista preciso, al seguire account Instagram che non ti “ottimizzano” il feed ma ti aprono universi inaspettati. È la stessa dinamica di chi sceglie il caffè di un piccolo torrefattore locale o il vestito di un designer indipendente: la cura come gesto culturale, che oppone profondità al rumore di fondo.
La cura è fatica
È sforzo di scoperta.
È l’amica che ti passa un disco con un “questo ti farà impazzire” e magari sbaglia, ma almeno ti apre una strada. È la cassetta mista degli anni Novanta, con pezzi che non avresti mai scelto. È la newsletter che ti fa trovare un libro fuori scaffale, il podcast che ti racconta perché un pezzo vale la pena, non solo quanto è virale.
Cura significa anche scegliere. Non tutto. Non sempre. Ma scegliere davvero. Non lasciarsi inghiottire dal “ti potrebbe piacere anche questo” infinito. Significa dire: questa è la mia playlist. Questo articolo lo condivido, quest’altro lo salto. Non delegare tutto a un algoritmo, che per definizione non ha desideri né cura.
E forse è qui il punto. La cura non è mai neutra: implica intenzione, investimento, tempo. È una forma di resistenza dentro un sistema che ci vuole scorrere via lisci e prevedibili. Che sia la salute, i dati o la musica che ascoltiamo, la cura è sempre un atto di attenzione radicale.
E poi c’è l’intelligenza artificiale
Che prende i nostri dati, li digerisce, li combina, li sputa fuori in nuove forme.
Testi, immagini, canzoni generate da modelli che macinano milioni di esempi. Eppure, quello che li rende davvero sensati non è la potenza del calcolo, ma la cura con cui noi - esseri umani - sappiamo leggerli e interpretarli.
I dati che produciamo sono umani perché portano dentro la nostra fragilità, le nostre emozioni, i nostri desideri. Non sono solo “materia prima” da estrarre e spremere: sono tracce di vite, sensibilità che meritano attenzione. È qui che la parola cura torna con tutta la sua forza: significa riconoscere che dietro ogni informazione c’è qualcuno, che non basta l’efficienza di un algoritmo per raccontare una storia.
La vera sfida, adesso, è questa: non lasciare che l’AI trasformi i dati in un miscuglio impersonale, ma prendersene cura come se fossero semi. Coltivarli con la nostra sensibilità, con la capacità di scegliere e di raccontare. Perché se i dati sono sensibili, è solo lo sguardo umano che li rende vivi.
Cura, in fondo, oggi è anche una parola che descrive il presente digitale meglio di molte altre. Non si parla solo di salute, ma di come ci stiamo attrezzando per non lasciarci travolgere. Nei dati, nella cultura, nelle piattaforme, la “cura” sta diventando una strategia. Nei musei, ad esempio, la curatela digitale non si limita a mettere online archivi sterminati: arricchisce le opere con storie, connessioni, percorsi che aiutano il visitatore a orientarsi e a sentire che quei dati hanno un contesto, un’anima. È una cura esperienziale, che mette al centro la relazione e non solo la catalogazione.
Un po’ medici di noi stessi
In questo scenario, la parola cura si intreccia con l’AI.
Le macchine sono bravissime a macinare numeri, a produrre varianti, a replicare pattern. Ma la qualità nasce quando l’intervento umano entra in gioco: corregge, filtra, racconta. È il modello ibrido che si sta consolidando in tanti settori: l’algoritmo propone, l’umano cura. E forse il trend più forte di tutti è questo: dopo anni di fiducia cieca nei consigli automatici, torniamo a desiderare voci umane. Curatori che ci guidino fuori dall’omogeneità, ci sorprendano con scelte inattese, ci facciano sentire che dietro ogni dato c’è un’intenzione. Una forma di resistenza, ma anche di speranza: perché in un mondo dove tutto può essere automatizzato, la cura resta irriducibilmente nostra.
E intanto, mentre scrivo queste righe, sto guarendo. La tosse è quasi sparita, l’ultimo orecchio si apre un po’ di più ogni giorno, la tosse è ancora un po’ grassa, l’energia torna piano piano (e sto rielaborando i miei dati ispirata dal long-Covid di Giorgia Lupi). La cura funziona così: non arriva come un interruttore che si accende, ma come un processo fatto di micro-gesti che si sommano. Vale per il corpo, vale per i dati, vale per la cultura che scegliamo di abitare.
La mia (quasi) guarigione è la prova che anche nei nostri mondi digitali la cura è una pratica quotidiana: ci vuole tempo, attenzione, e la capacità di lasciare che le cose trovino un nuovo equilibrio.